A distanza di dieci anni dalla sua uscita, il romanzo Accabadora di Michela Murgia torna a far parlare di sé. L’autrice è stata infatti ospite dell’incontro “Un silenzio sbagliato – l’eutanasia tra romanzo, medicina e bioetica”, tenutosi a Bologna il 12 febbraio 2019.

testo di Alice Spiga – direttrice di SO.CREM Bologna
Essendo stata presente all’incontro, posso dire che Michela ha affrontato il tema con grande competenza e sensibilità, dando un apporto importante al dibattito sull’auto-determinazione, sulla cura del morente e sul ruolo della famiglia e dello Stato, e su come questo ruolo sia cambiato nel corso del tempo.
Il romanzo di Michela Murgia è infatti uscito nel 2009, nello stesso periodo in cui in Italia ferveva il dibattito sul caso Welby e sul caso Englaro.
«Questi due casi – ha dichiarato la Prof.ssa Carla Faralli nella sua introduzione – hanno permesso di infrangere il “silenzio sbagliato” che gravava sul fine vita, dando il via a un dibattito che, dieci anni dopo, ha portato all’approvazione della Legge 219 sul consenso informato, sulle disposizioni anticipate di trattamento e sulla pianificazione condivisa delle cure. Chiediamo quindi a Michela Murgia di presentare il suo romanzo, mettendolo in relazione ai casi Welby ed Englaro».
Di seguito, la risposta dell’autrice Michela Murgia:

Michela Murgia durante l’incontro con Carla Faralli e Carlo Albarello
«Ho iniziato a scrivere il romanzo nel 2006 con l’intento di raccontare la filiazione d’anima, quindi la storia di una donna anziana che, nella Sardegna rurale degli anni ’50, si serve di uno schema comportamentale che è stato diffuso per molti anni (fino agli anni ’80): quello di diventare genitore del figlio di qualcun altro.
«Non si tratta di un affido, nemmeno di un’adozione: è un bambino che, pur avendo entrambi i genitori, viene cresciuto da un’altra donna che, per qualche ragione, non ha potuto avere figli propri».
E Michela ne parla con cognizione di causa, visto che lei stessa è figlia d’anima e ha due madri. E questo spiega la dedica del suo libro: “A mia madre. Tutte e due”.
«Quello che, quindi, ho voluto raccontare era la storia di una vecchia – Bonaria Urrai – che si affeziona alla figlia della vicina di casa e la chiede in figlia e, secondo gli accordi famigliari in uso all’epoca, la bambina le viene data. Non perde i legami con la famiglia di origine. Non è una figlia sottratta, è una figlia moltiplicata».
Nel romanzo si legge: “Sono bambini generati due volte: dalla povertà di una donna e dalla sterilità dell’altra”.
«Quello che avvicina il mio romanzo al tema di cui stiamo parlando è che Bonaria Urrai, di giorno, svolge il lavoro di sarta, mentre di notte viene talvolta chiamata al capezzale di qualche agonizzante per mettere fine all’agonia.
«E qui è importante capire che, in Sardegna, l’agonia è considerata un momento di espiazione: si crede che l’agonizzante abbia una qualche colpa che gli impedisce di andarsene accogliendo la morte. Solo nel momento in cui la coscienza sarà libera dalla colpa, l’anima sarà anch’essa libera di abbandonare il corpo.
«Inoltre, è un errore pensare che la morte sia la stessa sempre, in qualsiasi tempo e luogo. Se qualcuno, negli anni ’50, fosse caduto da un carretto riportando ferite tali da portarlo sull’orlo della morte, sarebbe probabilmente morto nel giro di poche ore o dopo pochi giorni, anche senza l’intervento dell’Accabadora.
«Oggi i miglioramenti tecnologici fanno sì che si possa vivere attaccati a una macchina per 17 anni, come è effettivamente successo a Eluana Englaro. Quindi, quello spazio di 17 anni è uno spazio nuovo, è lo spazio della lunga sopravvivenza che prima non c’era.
«Quello è uno spazio che ha fatto nascere domande etiche nuove, che non avrebbero avuto senso di esistere in un contesto di sussistenza rurale, come quello sardo del 1950, dove non c’era un welfare, dove non c’era un accudimento istituzionalizzato, strutturato, in carico allo Stato, ma dove tutto il peso della cura di un agonizzante o di una persona in stato vegetativo ricadeva integralmente sulla famiglia, che spesso aveva appena le risorse per la sopravvivenza e non poteva farsi carico di qualcuno che non era in grado di produrre.
«Quel contesto non è paragonabile al nostro, anche perché stiamo parlando di una comunità fortemente relazionata. Nelle piccole comunità rurali, le relazioni sono molto strette: in Sardegna, fino agli anni ’80, esisteva un “noi” ipertrofico e un “io” piccolo piccolo, cioè un senso di comunità e di pluralità molto strutturato e molto definito.
«In un contesto così coeso, la morte e la nascita non erano medicalizzate. La nascita e la morte sono “fatti della comunità” e, come tali, vanno gestiti all’interno della comunità stessa. Era quindi inconcepibile nascere o morire in mano a persone pagate, con le quali il morente non aveva una relazione, ma che svolgevano nei loro confronti solo una funzione.»
Nel romanzo, Bonaria dice: “Se si ha bisogno di qualcuno per nascere, si ha bisogno anche di qualcuno per morire. Non c’è nessun vivo che arrivi all’ultimo senza aver avuto padri e madri in ogni angolo di strada e io sono l’ultima madre che alcuni hanno visto”.
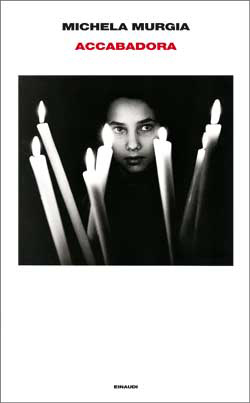
«In questo mondo, così gestito e concepito, l’Accabadora è un’estensione della cura della comunità, è una narratrice esperta in finali. Si tratta di una figura antropologicamente non provata, forse inesistente, ma che sintetizza un uso.
«Nel contesto rurale che ho descritto, era la donna a prendersi cura della famiglia, a occuparsi delle nuove nascite e, quindi, anche delle morti: è assai probabile che qualunque donna, al momento opportuno, sapesse che cosa fare.
«Quello che invece abbiamo e stiamo vivendo è un altro tipo di realtà: noi non viviamo più in una comunità di sussistenza iper-coesa, dove il noi è ipertrofico. Oggi c’è una soggettività molto più marcata, una società mononucleare ed è lo Stato che si occupa della cura del malato, come del morente.
«Nel contesto in cui si muove il mio romanzo, non avrebbero quindi trovato posto né il caso di Eluana – il padre, in quanto relazionato alla figlia, avrebbe avuto tutto il diritto di decidere – né il caso di Welby, perché lo Stato non avrebbe avuto modo di interferire sulla volontà espressa dal singolo».
